Le eliminazioni di alcune squadre da Playoff e Play-In stanno portando le dirigenze NBA a chiedersi cosa fare con i propri Head Coach. In questo clima di valutazioni, alcune panchine NBA sono già saltate: si è partiti con Stotts e Clifford, principali protagonisti di questo articolo, per arrivare a Bjorkgren, l’ultimo costretto a lasciare il proprio incarico. Chi siederà al loro posto probabilmente lo scopriremo fra vari giorni, ma intanto diamo un’occhiata a quali sono state le motivazioni che hanno fatto arrivare le dirigenze a queste scelte e proviamo a chiederci che tipo di Coach le squadre potrebbero (o dovrebbero) ricercare.
Un mare in tempesta
La stagione di Portland è stata l’ennesima conferma di come sia facile per una squadra NBA mettere l’àncora nel cosiddetto ‘Limbo’ e rimanerci per lungo tempo senza riuscire a smuovere le acque. Una stella come Damian Lillard è un lusso che non tutti possono permettersi nella Lega e le qualità della PG di Portland si sono riflettute sulle qualificazioni ai Playoff che i Blazers hanno inanellato in questi anni.
Al di là della striscia consecutiva di corse ai Playoff però, il finale di stagione 2020/21 ci restituisce un’organizzazione che sembra parzialmente allo sbando. In Oregon ci si è ritrovati ad interrogarsi su quei punti che dall’interno erano considerati certezze consolidate negli anni (il duo Lillard-McCollum e Coach Stotts) e l’offseason che si prospetta appare tutt’altro che semplice.
Dire “Dall’interno” non è una specificazione casuale. Se infatti nella franchigia la convivenza tra le due stelle della squadra è considerata un punto di partenza, ormai da più stagioni analisti ed osservatori mettono in dubbio l’efficacia a livello Playoff di un roster costruito su due guardie undersize ed entrambe più a loro agio palla in mano che senza. Chiedersi cosa fare con il duo è una questione che probabilmente sarà affrontata già a partire dalla firma del nuovo Head Coach, argomento del quale parleremo tra poco.
Nel frattempo l’uscita al primo turno contro Denver è stata l’ennesima delusione per una squadra che, escluso l’exploit del 2019, negli ultimi anni non ha mai dato l’impressione di poter andare oltre questo risultato. La presenza di una Superstar come Lillard dovrebbe imporre ad uno small market come Portland di fare di tutto per crearsi la chance di una run verso il titolo, ma un mix di mosse sbagliate e sfortuna non ha mai permesso alla franchigia nemmeno di incutere paura in nessuna contender ad ovest, né tantomeno di mostrarsi come una seria pretendente all’anello.
Le domande di cui si parlava prima si sono presentate di fronte a Neil Olshey con una rapidità impietosa ma che facilmente era immaginabile. Come lo sfortunato protagonista di qualche cartone animato o di qualche commedia degli equivoci, Olshey ha visto il fragile equilibrio che aveva costruito cadere un pezzo dopo l’altro. I problemi difensivi, che il GM pensava di aver risolto con Covington e Jones Jr, sono costati l’eliminazione per mano di una squadra priva di esterni capaci di crearsi un tiro e in giro per la lega hanno cominciato a circolare voci su interessamenti per Lillard da parte di vari team. Inoltre, le dichiarazioni di Jusuf Nurkić hanno svelato un segreto di Pulcinella: la salute dell’organizzazione non è delle migliori, a vari livelli.
Jusuf Nurkic: “My contract is non-guaranteed so I don’t know if I’ll be back. I’ll let Rich Paul my agent figure that out. I don’t know if I’ll be back. I don’t know what the direction of the team will be.”
— Sean Highkin (@highkin) June 4, 2021
Se la questione Damian Lillard è una suggestione che fa venire l’acquolina ai più grossi squali delle scrivanie NBA, va detto che le voci non sembrano avere particolare concretezza. Quello che però ci dicono è che Portland ora è davvero costretta a cambiare rotta per convincere la propria stella a non mettersi di traverso. Guardando in maniera decontestualizzata la classifica di fine stagione dei Blazers (sesti ad ovest, con un record di 42-30), non sembra di trovarsi di fronte ad una squadra in balia di acque così tempestose. In verità la maggioranza delle franchigie della Western Conference ha una situazione che fa guardare al futuro con decisamente maggiore fiducia, o per un roster più talentuoso o per uno young core che fa sperare in un miglioramento.
Il team dell’Oregon è riuscito a mantenere ancora per un anno la testa completamente fuori dall’acqua, grazie ad una striscia di vittorie di 10-2 per chiudere la stagione che ha salvato la squadra dal rischio del play-in. Il talento medio della Western Conference sembra però continuare ad alzarsi e le scelte fatte dalla dirigenza per mantenere la competitività hanno addensato le nubi sul futuro.
La cessione di Trent, seppur anche lui da rinnovare, per qualche mese di Powell a metà stagione, le due prime scelte offerte per Covington e la poca attenzione messa nello sviluppo di un giocatore con potenziale come Nassir Little sembrano le mosse frenetiche di un naufrago su una scialuppa che sta per affondare, che comincia a lanciare in mare tutte le sue cose per restare il più possibile a galla. Le vere risposte agli interrogativi dei Trail Blazers arriveranno con la scelta del Coach, lo snodo cruciale per il futuro.
Il Casting a Portland
La stagione di Portland, come detto, è stata una continua ricerca di un precario equilibrio che si è rotto definitivamente con l’eliminazione dai Playoff. Alla luce di questo risultato, la decisione della dirigenza è stata quella di prendere una strada diversa in vista della prossima stagione e separarsi da Coach Terry Stotts. Stotts è un allenatore che ha dato tanto alla franchigia, dopo essere arrivato nell’estate della grande rivoluzione di Portland, quel 2012 che ha visto approdare in Oregon anche il GM Olshey e Damian Lillard. Questo trio ha condotto la franchigia ai Playoff ininterrottamente già dalla stagione successiva al loro insediamento, anche grazie alla capacità dello stesso Stotts di creare una fase offensiva efficace, provenendo dalla scuola di Rick Carlisle, al fianco del quale aveva portato a Dallas il titolo 2011.
La scelta di Olshey di separarsi da Stotts credo possa essere imputata a tre diversi fattori: la fine naturale di un ciclo, la mancanza di un’identità difensiva e la ricerca di un capro espiatorio per un risultato che è stato percepito come un fallimento, nonostante fosse perfettamente in linea con le possibilità del roster.
Tutti e tre i motivi elencati, però, non sembrano poter essere letti come colpe di Stotts. Se infatti la grande delusione che ha serpeggiato tra franchigia e tifosi dopo l’eliminazione è stata il motore della decisione di Olshey, quest’ultimo appare probabilmente più colpevole dell’Head Coach, avendogli messo tra le mani un roster con lacune evidenti. Il secondo dei motivi citati e la principale causa del fallimento di Portland è la mancanza di tenuta difensiva (29th per Difensive Rating in stagione regolare), problematica che è sembrata naturale conseguenza della mancanza di un buon numero di difensori di livello nelle rotazioni, piuttosto che di un cattivo lavoro di Stotts.
Detto di due dei tre motivi ai quali è riconducibile la separazione dal Coach, rimane l’ultimo, che è anche il più importante, poiché potrebbe essere segno di cambiamenti radicali: la fine di un ciclo. Se infatti a guidare la decisione di Olshey fosse davvero stato principalmente questo, sarebbe lecito cominciare ad immaginare una mini rivoluzione in Oregon, a partire dalla scelta dell’allenatore, fino ad arrivare alla costruzione del roster.
L’idea cardine che dovrà guidare la scelta dovrà essere senza dubbio quella di trovare un allenatore in grado di implementare idee di sviluppo e costruire un’identità difensiva. Se infatti è vero che Lillard ha ormai superato i 30 anni e chiede la costruzione di un roster competitivo, anche prendendo ulteriori rischi, vanno considerati due aspetti rilevanti: il primo è che con il solo Lillard come “vera” stella è impossibile puntare al titolo, quindi sarebbe preferibile scegliere dei giocatori più funzionali ad un’idea di basket organizzato e capace di elevare il livello di interpreti piuttosto che ammassare più talento possibile, e il secondo è che continuando a sacrificare giovani e stelle per mantenere un roster da primo turno è probabile che alla partenza di Dame saranno rimaste solo macerie nella franchigia.
Se è difficile capire chi sarà a tutti gli effetti il prossimo allenatore di Portland, dal momento che Olshey ha dichiarato di avere una rosa di oltre venti candidati, è possibile fare intanto una considerazione su qualche nome venuto fuori in questi giorni:
Among candidates expected to be considered for the Blazers opening, sources tell ESPN: Clippers assistant Chauncey Billups, Jeff Van Gundy, Nets assistant Mike D’Antoni, and Michigan’s Juwan Howard.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2021
Innanzitutto è bene partire dalle dichiarazioni di Damian Lillard, il quale ha espresso di gradire Billups o Kidd, rispettivamente assistenti di Tyronn Lue e Frank Vogel, sulla panchina di Clippers e Lakers. Appare evidente che Dame sia influenzato dallo status dei due, entrambi ex playmaker molto carismatici e vincitori di anelli con squadre dal gioco corale. Se il primo si vocifera che sia uno degli Assistant Coach più promettenti della NBA, nonostante sia solo al primo anno, Kidd ha dimostrato di non essere un allenatore di alto livello nelle sue avventure a Brooklyn e Miwaukee, finendo per essere ricordato positivamente solo per i suoi rapporti con alcuni giocatori, favoriti dal suo status. Quest’ultimo si è recentemente dichiarato lusingato dall’interesse della franchigia, ma ha pubblicamente detto che non sarà il prossimo Head Coach di Portland, facendo trasparire che ci sia già stato un colloquio andato male o che sia più interessato a un altro posto di lavoro.
The Portland Trail Blazers are increasingly expected to hire Clippers assistant Chauncey Billups or Lakers assistant Jason Kidd as franchise’s next head coach, sources tell me and @jwquick.
— Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2021
Exclusive comments from Damian Lillard and more on @TheAthletic: https://t.co/NcU6DoUCK0
Gli altri nomi che sono stati fatti da Woj sono nomi di Coach decisamente più esperti come Mike D’Antoni e Jeff Van Gundy. L’ex Rockets e Suns è un allenatore che porterebbe sicuramente un ambiente sereno e una decennale esperienza nel costruire sistemi offensivi funzionanti attorno alla propria guardia ball-dominant, come fatto con Nash ed Harden. Questo progetto però appare piuttosto complicato da riportare in auge con Lillard, una stella con capacità di creazione per gli altri molto più limitate e, in generale, un giocatore di livello inferiore rispetto ai due precedenti alfieri dell’idea di basket di D’Antoni. L’attuale Assistant Coach dei Brooklyn Nets sembra comunque essersi dichiarato seriamente interessato al ruolo di HC di Portland, probabilmente per cercare l’ultima grande occasione su una panchina NBA.
Van Gundy, invece, non siede su una panchina NBA dal 2007 e, per quanto apprezzato come analista e commentatore, è difficile immaginarlo prendere in mano i destini della franchigia dell’Oregon.
L’ultimo nome, probabilmente il più complesso da raggiungere ma anche il più suggestivo, è Juwan Howard. L’attuale Coach dei Michigan Wolverines è uno dei giovani allenatori più promettenti d’America. Dopo aver preso in mano la panchina della sua Alma Mater, nella quale si era fatto conoscere come uno dei famosi ‘Fab Five’, Howard ha portato a casa ottimi risultati negli ultimi due anni, riportando il titolo della Big Ten a Michigan dopo sette anni e vincendo il premio di COTY della conference.
Howard è riuscito a raggiungere praticamente ogni obiettivo che ad un Coach di college può essere richiesto: ha costruito una squadra solida su due lati del campo, integrando giovani e upperclassmen, ha sviluppato il talento di prospetti NBA come Franz Wagner, Isaiah Livers ed Hunter Dickinson ed ha portato a casa dei recruitment di assoluto livello, ossia due prospetti top10 della nazione in uscita dall’High School come Caleb Houstan e Moussa Diabate.
Prediction: There are plenty more tears of joy to come. #OTD in 2019, @JuwanHoward was introduced as @umichbball head coach. 〽️ pic.twitter.com/qbH4wqCI4c
— Michigan On BTN (@MichiganOnBTN) May 30, 2021
Si è detto che Juwan Howard fosse una pista complicata e infatti ultime ore sono uscite alcune dichiarazioni del coach che non lasciano ben sperare per un futuro approdo in NBA. Nonostante ciò, è giusto segnalarne il nome perché rappresenta ciò che Olshey dovrebbe cercare per la panchina di Portland: un coach giovane, con buone capacità di adattamento e di relazione con i giocatori. Tramite i risultati e l’ottimo recruiting, Howard ha dimostrato di poter essere un coach di alto livello in entrambi gli aspetti e i Trail Blazers dovrebbero cercare qualcosa di simile per rilanciare davvero un nuovo ciclo, che possa portare un’aria nuova e che renda davvero motivata la scelta di separarsi da Terry Stotts, al quale i tifosi dovrebbero comunque rivolgere dei sentiti ringraziamenti per la striscia di qualificazioni consecutive ai playoff degli ultimi anni.
La magia è finita
L’obiettivo stagionale degli Orlando Magic era quello di centrare uno storico three-peat, accedendo per la terza volta consecutiva ai playoffs sotto la guida di Coach Steve Clifford (non accadeva dai tempi di Dwight Howard). E probabilmente ce l’avrebbero fatta (magari passando per il play-in tournament) se non fosse stato per una sfilza infinita di infortuni. Questa potrebbe sembrare la classica frase pronunciata da un villain di un episodio di Scooby Doo appena smascherato dalla banda capitanata dal famoso alano, eppure descrive alla perfezione la disastrosa annata dei cugini meno glamour dei Miami Heat.
Ai nastri di partenza la squadra si presentava con un organico quasi invariato rispetto alla stagione precedente, con i soli Jonathan Isaac (infortunio) e D.J. Augustin (accasatosi ai Bucks) come assenti tra i giocatori di rotazione, rimpiazzati da Dwayne Bacon e il rookie Cole Anthony. Il sistema offensivo implementato da Coach Clifford era imperniato su Nikola Vučević, stella della squadra, su un Markelle Fultz in rapida ascesa, sul solito contributo di Fournier e sui lampi di talento di Aaron Gordon.
La fase difensiva, invece, era l’aspetto del gioco su cui l’ormai ex-Coach dei Magic lasciava maggiormente la sua impronta: senza un rim protector di livello e con, anzi, due minus difensivi come Fournier e Vučević, Clifford nei tre anni passati a Orlando ha sempre saputo restituire una solida identità difensiva al proprio roster, basata su rapide ed efficaci rotazioni difensive e soprattutto su pochi falli commessi, e quest’anno non sarebbe stato da meno.
I sogni degli Orlando Magic, purtroppo, si sono infranti con l’infortunio al ginocchio subito da Markelle Fultz nell’ottava partita di regular season, il primo di una lunga serie per la franchigia della Florida: dopo una partenza da 6 vittorie in 8 partite, i Magic ne hanno perse 21 delle successive 28, per poi vincerne appena altre 8 nelle restanti 36. Come è stato anticipato in precedenza, il pessimo record di 21-51 di fine stagione è dovuto soprattutto ai numerosi infortuni, a cui il solo Dwayne Bacon è stato esente, scendendo in campo in tutte e 72 le partite (il secondo tra i giocatori non scambiati è Cole Anthony a quota 47). Coach Clifford è stato quindi costretto a cambiare ben 32 quintetti titolari, alcuni dei quali, come potete leggere, appartenevano più alla G-League che alla NBA.
Per curiosità sono andato a recuperare tutti e 32 i quintetti titolari utilizzati dai Magic durante la scorsa regular season (sesto dato più alto nella lega).
— Davide Possagno (@DavePos5) June 10, 2021
Ovviamente ho avuto il privilegio di ammirare le gesta di tutti e 32. pic.twitter.com/uf9vZcntMZ
Con così tanti cambiamenti nelle rotazioni e con i ritmi serrati di questa stagione accorciata l’obiettivo dei Magic è sfumato piuttosto rapidamente, spostando l’attenzione al prossimo draft. La dirigenza ha quindi deciso di cambiare completamente rotta dedicandosi totalmente al rebuilding e allo sviluppo dei giovani, spedendo Vučević e Aminu a Chicago, Fournier a Boston e Aaron Gordon a Denver, per dare più spazio a Cole Anthony, Chuma Okeke, Mo Bamba, Wendell Carter Jr. (proveniente dai Bulls) e R.J. Hampton (da Denver).
Nonostante un roster inesperto, poco profondo e non particolarmente talentuoso, i nuovi Magic hanno sempre venduto cara la pelle, rispondendo colpo su colpo anche a squadre sulla carta molto più forti di loro, salvo poi arrendersi nei quarti finali per ovvi motivi. Parte del “merito” è da attribuire a Coach Clifford, il quale, nonostante non sia tra i migliori sulla piazza a sviluppare i giovani, ha saputo dare le giuste responsabilità alle nuove leve, mettendole in condizione di esprimere il proprio potenziale. Tra tutti hanno brillato Cole Anthony (diventato titolare dopo l’infortunio di Fultz), R.J. Hampton, specialmente nelle ultime 10/15 partite, ma soprattutto Chuma Okeke, vera rivelazione di questa squadra, in grado di impattare positivamente numerose partite in entrambe le metà campo.
Just Chuma Okeke doing beautiful things on both ends of the floor to bless your timeline❤️ pic.twitter.com/6cBdDyqY1I
— Davide Possagno (@DavePos5) April 11, 2021
Un nuovo inizio a Orlando
Come anticipato nel paragrafo precedente, lo scorso cinque giugno le strade degli Orlando Magic e di Coach Steve Clifford si sono consensualmente separate, con la squadra della Florida decisa finalmente a intraprendere una ricostruzione rinnovando anche il coaching staff.
As the Orlando Magic move into a full rebuilding process, coach Steve Clifford and the franchise have agreed together to a parting, sources tell ESPN.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2021
Dopo aver ingaggiato tre anni fa Clifford per conquistare un posto ai playoffs dopo diversi anni, l’obiettivo attuale dei Magic è diventato lo sviluppo dei tanti giovani a roster, e per farlo l’ideale sarebbe firmare un allenatore in grado di massimizzare il talento di ognuno di loro, creando passo dopo passo una nuova identità di squadra.
Per questo motivo, personalmente ritengo che una strategia efficace potrebbe essere simile a quella adottata dagli Charlotte Hornets (fatalità anche loro per il post-Clifford), ovvero ingaggiare un coach relativamente giovane con alle spalle un passato da vice-allenatore in ottime squadre o proveniente dalla G-League, viste le numerose storie di successo di allenatori provenienti da quel contesto. Il licenziamento di Clifford è ancora fresco e la stagione NBA deve ancora finire, di conseguenza al momento è difficile formulare ipotesi fondate; i nomi che circolano sono sempre i soliti: da Billups a Udoka, passando per Stackhouse e Becky Hammond, con la suggestione Penny Hardaway, attualmente più romantica che concreta.
I Magic hanno già un nucleo di giovani piuttosto variegato, composto da Fultz, Anthony, Hampton, Isaac, Okeke, Carter Jr. tutti giocatori con qualche limite in attacco, ma già più sviluppati per quanto riguarda la fase difensiva; potrebbe essere interessante sondare il mercato degli allenatori per trovare un profilo più abile a creare una fase offensiva efficiente mettendo in secondo piano quella difensiva, viste le qualità già presenti nei singoli.
Da qui il nome di Terry Stotts, in uscita da Portland dopo otto stagioni in cui la franchigia dell’Oregon è rimasta competitiva grazie al suo attacco piuttosto che alla sua difesa. Certo, i Magic non hanno Damian Lillard a roster, ma possono contare su giocatori dai diversi skillset che, se sviluppati correttamente, potrebbero comporre gli ingranaggi di una macchina offensiva da non sottovalutare.
Personalmente rimango dell’idea che cercare un volto nuovo rispetto a quelli noti al panorama NBA nel ruolo di Head Coach, in grado di crescere assieme alla propria squadra, sia il percorso più sensato, ma optare per un allenatore più navigato per rendere già da subito un minimo competitivo l’ambiente potrebbe ripagare ugualmente.
Nate Bjorkgren, l’ultimo caduto tra gli allenatori NBA
Prima di concludere questo articolo, è doveroso citare l’ultima panchina saltata in NBA, nella notte italiana tra il 9 e il 10 giugno. Nate Bjorkgren, l’Head Coach assunto dagli Indiana Pacers ad inizio stagione, non è riuscito a guadagnarsi la riconferma, a causa dell’eliminazione ai Play-In per mano di Washington, ma soprattutto a causa di un rapporto con la squadra mai decollato.
L’assistant coach uscito dallo staff a metà stagione lamentando problemi di chimica, la famosa polemica in campo di Bitadze, i rumors su TJ Warren che avrebbe scelto di rimanere out for the season per non giocare per Bjorkgren, suo ex coach in G-League, e infine il GM Pritchard, che aveva già dichiarato di star valutando la posizione di Bjorkgren, non dimostrando una particolare fiducia. Tutti i segni che qualcosa non andasse e che hanno portato alla notizia della separazione.
Indiana’s Kevin Pritchard says “no decisions have been made” on the future of Coach Nate Bjorkgren, adding that, while Bjorkgren did “some good things” in Year 1, there are “things he needs to do better.”
— Marc Stein (@TheSteinLine) May 24, 2021
Interesting views enclosed from @McDNBA, who has been in Pritchard’s seat: https://t.co/YOCwoEONkS
Se l’Head Coach della franchigia di Indianapolis si è presentato come un vero mago degli X’s & O’s, allo stesso tempo non è riuscito in due aspetti fondamentali: costruire un rapporto solido con la squadra e adattare le sue idee di gioco ai giocatori a disposizione. La dimostrazione di ciò sono gli schemi difensivi che Bjorkgren ha provato ad implementare, naufragati con l’assenza di Turner e culminati con i 142 punti presi da Beal e compagni nella gara decisiva del Play-In Tournament. La prima delle due questioni è stata invece la più importante tra quelle valutate da Pritchard nella scelta di separarsi da Bjorkgren, poiché era complicato andare avanti con un Coach così in difficoltà nei rapporti con i giocatori.
Ora davanti alla franchigia dell’Indiana si pone una scelta complicata naufragato il progetto a lungo termine che si pensava di poter costruire con Nate Bjorkgren. Se il roster rimanesse così com’è, la franchigia potrebbe decidere di portare a casa un Coach offensivo che possa massimizzare il talento a disposizione, ad esempio lo stesso Stotts. Se Indiana invece decidesse di cambiare, il ventaglio di scelte diventerebbe decisamente più ampio, seppur il fallimento del progetto Bjorkgren potrebbe indurre la dirigenza a guardare ad un allenatore con più esperienza da Head Coach.













































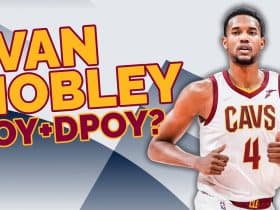



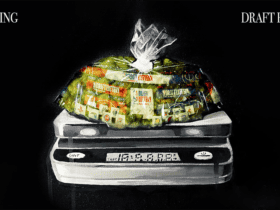








Lascia un Commento
Mostra i commenti