Per un attimo – ad una manciata di giorni dal via della postseason 2022 – avevamo sperato tutti di trovarci di fronte ad un’edizione diversa rispetto a quella passata.
E l’intensità o le sorprese non c’entrano niente con le aspettative comuni alla totalità dei fans sparsi per il mondo.
I Playoff 2021 erano stati letteralmente funestati dagli infortuni alle grandi stelle, tanto da far gridare a molti (per lo più in malafede) che il risultato finale degli incroci non poteva che esser viziato dalla fortuna o meno.
Certo, la scorsa stagione venivamo da una offseason cortissima, e da una stagione condensata in piena emergenza Covid, con la NBA concentrata a non perdere quelle date decisive per il recupero economico dei grandi diritti televisivi. Come ad esempio il Christmas Day, che rischiava di venir decurtato dalla programmazione calcolando l’estremo ritardo con cui il campionato finito nella bolla di Orlando aveva decretato il suo vincitore.
Al cadere di un campione dopo l’altro, si erano risollevate polemiche annose anche provenienti da nomi altisonanti e, con i Bucks sul tetto del mondo e una serie canonica di mesi di riposo a venire, potevamo sperar di aver lasciato dietro il peggio. Giochi Olimpici permettendo, e quindi escludendo i partecipanti alla spedizione Team USA.
They all didn’t wanna listen to me about the start of the season. I knew exactly what would happen. I only wanted to protect the well being of the players which ultimately is the PRODUCT & BENEFIT of OUR GAME! These injuries isn’t just “PART OF THE GAME”. It’s the lack of PURE
— LeBron James (@KingJames) June 16, 2021
Ed invece, a poche ore dal play-in, il copione è sembrato ripetersi con l’infortunio di Luka Dončić durante l’ultima sfida stagionale di Dallas, sostanzialmente quasi inutile ai fini del piazzamento.
Una sliding door pazzesca, se pensiamo che lo sloveno avrebbe dovuto non partecipare alla partita in quanto squalificato per raggiunto limite di tecnici fischiati contro di lui. Con il senno di poi, una manna resa vana dal ricorso dei Mavericks, accolto con successo.
Insomma, l’incubo torna a manifestarsi rapidamente. In primis per la lega che non solo perde subito (e apparentemente a tempo indefinito) uno dei protagonisti più attesi, ma vede giocatori chiave di squadre con velleità di successo cadere uno dopo l’altro.
Devin Booker e Khris Middleton dopo le rispettive gare 2, e poi Kyle Lowry e Joel Embiid. Ed a seguire fastidi che generano incertezze – come quello accaduto a Donovan Mitchell e Jimmy Butler – da sommarsi agli assenti ormai perenni di Nuggets e Clippers, con l’eterno valzer del dubbio ad abbracciare Zion Williamson ed un Ben Simmons che alla fine non scenderà in campo entro l’eliminazione dei “suoi” Nets. Senza contare la spada di Damocle permanente degli health and safety protocols.
Dalle supposizioni appassionate per un’edizione incerta, siamo passati velocemente alle previsioni di rientro ed i calcoli consequenziali. Anzi, quella paranoia circoscritta ad ogni brutta caduta sul parquet su azione di gioco, è tornata a farsi largo durante ogni sfida che si rispetti.
Si attende solo di capire chi sarà il prossimo, facendo i dovuti scongiuri per la propria squadra. Come se si trattasse di nuovo di una sfida di sopravvivenza: rimanere il più integri possibile per vincere, investendo tutto sulla cosiddetta dea bendata.
Ancor meglio, con quella percezione dello scontro annuale governato da forze oscure (in questo caso) che impongono un orizzonte delineato ai partecipanti della competizione a scontro diretto: lottare senza esclusione di colpi, contro scorrettezze e a svantaggio di stress, perché vince chi metaforicamente non muore. Un gioco ad esclusione che sembra compiersi sullo stato di salute dei partecipanti, con l’eliminazione “per sempre” che ne determina le sorti dietro l’angolo. In poche parole, tipo Hunger Games.
La domanda che sorge spontanea, alla fine del tutto, è quanto tutto questo possa danneggiare la qualità del prodotto offerto dalla NBA, calcolando l’alto rischio di veder gli uomini di punta sui quali franchigie e lega hanno investito (sia a livello di gioco che di marketing) cadere uno dopo l’altro.
E se esiste un modo per evitarlo, almeno in futuro se non a partire da adesso.
Una variabile parte del gioco
Per certi versi appare utopistico sperar di cambiare un trend simile, ammesso che di trend recente si tratti, a prescindere dagli accorgimenti organizzativi del caso.
Certo, si può pensare che le 82 partite stagionali siano troppe, ed indirettamente gettar ancora la croce addosso al non pieno recupero della routine pre-pandemica. Ammesso che gli echi di due stagioni praticamente consecutive tra conclusione e ripresa, non siano stati assorbiti.
Che non sia poi l’epoca migliore per far programmi a lungo termine, lo dice apertamente la sorte toccata a Zach LaVine ad un giorno dall’ipotetico elimination game dei Bucks contro i suoi Bulls.
Durante l’antivigilia della sfida, con Alex Caruso in dubbio ed un Lonzo Ball ormai fuori dai giochi da tempi immemori, il numero 8 di Chicago si è ritrovato dentro i protocolli anti-Covid. Con poche chance di uscirne in breve termine.
Ovviamente le attenzioni sono diminuite drasticamente rispetto ai tragici mesi invernali, in cui i roster delle franchigie contavano più giocatori positivi che disponibili, eccezion fatta per i contratti quindicinali a funzionar da tappabuchi.
Ma il virus non si è certo spento come se fosse stato cliccato un interruttore, e la paura aumenta.
Sensazione ampiamente provata dai Sixers nelle sfide da disputare in quel di Toronto, con politiche di controllo canadesi decisamente più severe, ed una attività di testing continua.
Tanto da poter pericolosamente trovar qualche “asintomatico di lusso” nelle fila avversarie, provenienti dagli States. Della serie: potresti anche passar la postseason per gran parte senza gravi problemi fisici, ma se il virus ti riprende durante le Finals, non ci sono accorgimenti che tengono. È un rischio comune a tutti, e diviene quindi parte del gioco.
E lo stesso vale generalmente per quel vince l’ultimo sopravvissuto alla Hunger Games, come metafora per l’infortunio sempre dietro l’angolo.
Perché sia che si tratti di affaticamento progressivo, o di scontri meno controllati rispetto alla regular season, tutto è da rapportarsi alla fisicità degli atleti in gioco, e alle estremizzazioni consequenziali che il gioco ha fatto sue.
È vero infatti che un tempo – come tanti nostalgici continuano a sottolineare in gratuita polemica contro il presente – i grandi campioni mancavano raramente gli appuntamenti decisivi. Eppure si trattava di una pallacanestro più fisica, con meno tutele arbitrali e più concessioni.
Non si tratta però di una questione di “durezza” o “impavidità”, ma di un semplice sviluppo dei giocatori, in parallelo con le mutazioni naturali che la pallacanestro ha accolto.
Anzi, uno sviluppo fisico che naturalmente ha generato un gioco atleticamente più insostenibile, con ritmi forsennati e contatti più duri da assorbire di quel che sembra guardandoli alla TV.
Sicuramente più duri dell’epoca che fu, quando per narrativa comune “ci si picchiava sotto i tabelloni”.
Questo inevitabilmente influenza anche e soprattutto la regular season, all’interno della quale la gestione è divenuta necessaria più di un tempo. Ed è comunque sempre esistita, anche se trent’anni fa effettivamente non si parlava di load management. Ma non ce n’era bisogno, perché le partite erano sempre 82, ma i ritmi decisamente più bassi.
Contemporaneamente, pensar che il rischio infortuni – o peggio, gli infortuni stessi – non abbiano deciso le stagioni sarebbe un errore madornale. Seppur il volume registrato negli ultimi due anni appaia nettamente superiore, ma per onestà intellettuale non possiamo dimenticare l’edizione 2019 e le sfortune dei Warriors prima e durante le Finals. Secondo molti decisive per il titolo Raptors, pur tralasciando lo stato in cui Kawhi Leonard disputò gran parte delle run playoff.
Riuscendo a restar in piedi fino alla fine, decisivo. A proposito della sopracitata critica alla “durezza” e alle “impavidità” dei giocatori moderni di cui sopra (discorso che riguarda, stessa serie anche la volontà di scender in campo dei vari Thompson e Durant, che l’avrebbero pagata a lungo. E volendo anche di Cousins).
I più gravi infortuni di sempre nella storia della postseason
Magari, per una questione di impatto e per la non troppa distanza dall’evento, il primo che viene in mente è Derrick Rose che da MVP in carica, rimane a terra nell’edizione del 2012 contro i Philadelphia 76ers. La sua carriera cambierà diametralmente da quel giorno, e si parlerà tantissimo delle conseguenza di uno stile di gioco atleticamente estremo, utilizzato per la lunghezza di una stagione.
Ma a tutela del fatto che quando si giunge ai playoff il rischio è comune a tutti – ed incalcolabile nel manifestarsi – è scritto nella storia della NBA anche meno recente. Seppur la duplice assenza di Kevin Love prima e di Kyrie Irving poi, abbia funestato le Finals 2015 per LeBron James tanto quanto accaduto nel 2019 ai Warriors, a vantaggio dei Raptors.
L’assenza di un Karl Malone in realtà ben avanti sul cosiddetto viale del tramonto, è stata portata spesso a giustificazione per il fallimento del superteam Lakers del 2003, in finale contro i Pistons. Forse eccessiva, ma a tutela che il logorio progressivo di un infortunio lasciato da parte giocandoci sopra, porta comunque ad un finale amaro. Poco importa l’eroismo.
Discorso analogo per il Patrick Ewing del 1999, nella sua ultima possibilità di vincere un titolo a New York. Infortunandosi in gara 2 delle Conference Finals contro i Pacers – ed in modo irreversibile trattandosi di tendine d’Achille ad un’età già veneranda o quasi – e provando a restare stoicamente in campo, al suo normale gettar la spugna sfumano le ultime speranze dei Knicks. Che riusciranno comunque a stringere i denti giocando le Finals contro gli Spurs, ma che sentiranno la mancanza del suo peso nel pitturato, dovendosi scontrare con le Twin Towers formate da Duncan e Robinson.
O ancora, come dimenticarsi Isiah Thomas di gara 6 dell’ultimo atto 1988, con i Pistons che coronano il sogno di giocarsi il titolo contro i Lakers dello showtime. E malgrado la brutta slogatura della caviglia in gara 6, capace di disputar un sensazionale terzo quarto da 25 punti sostanzialmente su una gamba sola, insufficiente per vincere partita e poi serie.
E potremmo andar avanti ancora, con storie andate meglio (tipo la conosciuta e simbolica presenza di Willis Reed in gara 7 delle Finals 1970) ed altre che hanno visibilmente minato i destini di una run playoff.
Ad esempio, uno fra i tanti infortuni di Chris Paul, il Nowitzki contro gli Spurs del 2003, Byron Scott e Magic Johnson nelle finali del 1989, Bill Walton contro i Sonics nel 1978, e ancor più indietro nella storia Elgin Baylor che si rompe il ginocchio nel 1965 o addirittura Bill Russell, che in gara 3 delle Finals del 1958 contro i St.Louis Hawks si gira gravemente la caviglia. Con i Celtics che perdono la chance di vincere il secondo titolo consecutivo, anche se grazie proprio a Bill ne avranno altri 10 da alzare al cielo nel futuro prossimo.
Insomma, cambieranno i volumi e le impressioni, ma il destino avverso non decide certo i finali di stagione da poco. Anzi, nel ricordare solo quegli infortuni capaci di cambiar volto a serie decisive e dimenticare quelli che ne influenzano il resto, potremmo dire che niente è cambiato. Neanche il normale stupore con cui il tifoso medio accoglie il proverbiale “what if”, di fronte ad un qualcosa che appare incontrollabile, magari facile nel ricercar responsabilità dirette o indirette, ma comunque di cui tener conto sempre. Come imprevisto.
Come cambiano le dinamiche
Cerchiamo quindi di fare una chiosa sulla questione, ribadendo quanto il rischio infortuni sia comune a tutti per chilometraggio percorso in un gioco tremendamente intenso disputato da corpi potentissimi. E senza dimenticare che quella degli infortuni è una dinamica presente da sempre, in avvicinamento alla coda stagionale.
A poche ore da una gara 5 apparentemente semplice da vincere, conducendo la serie per 3 a 1 in modo piuttosto agile, i Miami Heat si ritrovano non solo senza Kyle Lowry e con Pj Tucker, Caleb Martin e Gabe Vincent in dubbio (giocheranno poi tutti e tre). Ma scoprono che a causa di una infiammazione del ginocchio dovranno scendere in campo contro Atlanta anche senza Jimmy Butler. Non esattamente la situazione ideale, in prospettiva.
Eppure, stringendo i denti e rispolverando un redivivo Victor Oladipo, vincono e passano il turno.
Saldamente in vantaggio per 3 vittorie a 0, i Philadelphia 76ers scoprono che l’uomo decisivo per le sorti playoff della squadra – Joel Embiid – si è lacerato il tendine del pollice della sua mano destra. Resta ugualmente a disposizione, perché il problema non può complicarsi né risolversi senza un’operazione programmata a fine stagione, ma perdono le due partite consecutive a seguire contro i Raptors. E la serie appare riaperta.
Malgrado lo stesso Embiid avesse letteralmente fatto fuori il Rookie of the Year Scottie Barnes, anche lui rientrato più velocemente del previsto, seppur lontano dal top della condizione. Calcolando pure l’assenza di Fred VanVleet per uno stiramento all’anca sinistra. Insomma, un misto tra i sopracitati Hunger Games ed un alternarsi di contrappassi da rendere un finale apparentemente scritto, quasi incerto.
Le due squadre probabilmente più accreditate per un rematch delle Finals 2021 – Milwaukee Bucks e Phoenix Suns – si scoprono improvvisamente più corte durante le rispettive seconde sfide in un primo turno piuttosto semplice sulla carta. Come già detto fuori Booker e fuori Middleton, ed entrambe cadono alla fine dei 48 minuti in modo imprevisto. Certo, anche a causa delle assenze Bulls, i campioni in carica si fanno bastare quantomeno per raggiungere un tranquillo match point in gara 5.
Ma la squadra con il miglior record della stagione regolare – senza il miglior realizzatore del gruppo, e non solo – fatica tremendamente con i Pelicans, presentandosi alla stessa quinta sfida sul 2 a 2. E scoprendo in Mikal Bridges un protagonista quasi inatteso, appoggiandosi alla sua straordinaria prestazione anche offensiva per prendere il controllo dell’incrocio, pur faticando.
Nel frattempo, nella serie che decreta il secco sweep di Boston a vantaggio di Brooklyn, l’attesissimo Simmons (praticamente dichiarato in campo per gara 4), soffre di ricadute alla schiena ed improvvisi problemi di equilibrio mentale, almeno ufficiosamente. Non solo non rientra, ma osserva dalla panchina l’improvviso ritorno di un Robert Williams che in teoria rischiava di saltare il primo turno, recuperato in tempo record per gara 3 dai Celtics. L’effetto sorpresa si consuma al contrario delle attese, aiutando lo scontro tra le due squadre a direzionarsi verso una rapida soluzione. Altrettanto imprevista.
Discorso analogo rispetto al Luka Dončić di cui sopra, con i Mavs che resistono a Utah portandosi in vantaggio nella serie senza di lui, dopo aver perso in gara 1. Facendosi riprendere in gara 3 malgrado una prestazione ottima dello stesso (seppur in apparenza appena al 60%), ma vedendolo decidere la sfida seguente riconquistando il vantaggio.
E potremo andare avanti ancora, soprattutto scrivendo questo pezzo tra qualche settimana, perché di “imprevista” sotto forma di infortuni di gioco o per banale “usura”, probabilmente ne vedremo di ulteriori.
Insomma, gli equilibri cambiano già velocemente in una lega tanto piena di talento, ed apparentemente mai tanto livellata tra le potenziali contender. Figuriamoci quanto possono assottigliarsi i divari per una semplice assenza, o per una presenza non al pieno della forma.
Dobbiamo tenerne conto, ed accettarlo. Perché per quanto appaia banale è doveroso ripeterlo: la sfida con il destino è comune a tutti. Rispetto ai contatti, magari, il focus dovrebbe essere sulla coerenza (o meno) dei fischi arbitrali. Altro problema ampiamente sottolineato in questo primo turno, del quale avrebbe senso parlare in separata sede.
Da una parte lo spettacolo potrebbe risentirne, è vero. Soprattutto se ci si aspetta che questo sia coincidente con la presenza in campo dei grandi campioni. Che chiaramente contribuiscono in modo decisivo, e non solo per hype, ma non necessariamente determinano la bellezza o meno di una serie.
Soprattutto se l’incertezza e le sorprese stanno alla base delle aspettative dei singoli spettatori.













































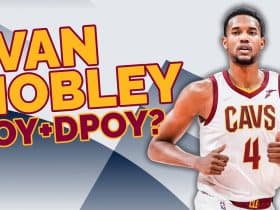



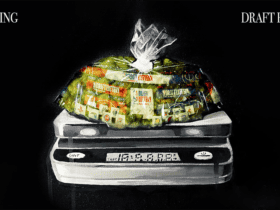








Lascia un Commento
Mostra i commenti