Costringendo i Lakers al fallimento di un tentato back to back, ed imponendosi con un secco sweep sui rimaneggiati Nuggets dell’MVP Nikola Jokic, i Phoenix Suns dimostrano al mondo che quello che si è vociferato a lungo – per tutta la regular season 2020/2021 – è sostanzialmente privo di fondamento.
Non è che le grandi squadre che “snobbano” parte delle 72 gare stagionali (in questo caso), lo fanno perché in grado di accendersi quando conta. Il campionato serve, si sperimentano giochi ed equilibri, ed il record che rispecchia porta con sé un valore assoluto non solo da calcolarsi con il vantaggio del campo in una serie.
Se poi, ad un gruppo giovane capace di giocar bene, hai aggiunto un lottatore come Jae Crowder – già arma segreta degli Heat nella cavalcata verso la finale durante la bolla di Orlando – ed una delle migliori point guard di sempre che risponde al nome di Chris Paul, tutto questo vale molto di più. A maggior ragione.
Con 51 vinte e 21 perse, la squadra dell’Arizona ha collezionato il secondo miglior record della lega, e come ben sappiamo ha conquistato le Conference Finals con più di una speranza per poter guardar oltre. Dove fino ad oggi sono arrivati solo altre due volte, senza mai togliersi la soddisfazione di alzare al cielo il Larry O’Brien Trophy.
È quindi il momento giusto per volgere lo sguardo indietro, ripercorrendo le tappe fondamentali nella storia della franchigia ai playoff. Chissà che partendo da queste, a fine della cavalcata in corso non ci siano da aggiornare record e riconoscimenti, con il sogno di disputare una stagione storica, magari la migliore di sempre nella storia della squadra.
Il primo incredibile viaggio alle NBA Finals
Suns esordiscono nella National Basketball Association nella stagione 1968/69, insieme ad i Milwaukee Bucks, quest’ultimi destinati ad accogliere ben presto Lew Alcindor da UCLA ed Oscar Robertson proveniente dai Cincinnati Royals. Inutile dire che raggiungeranno rapidamente la vetta della lega, vincendo il loro primo ed unico titolo nel 1971. In Arizona, invece, la nuova franchigia prende parte alla postseason direttamente al secondo anno, uscendo rapidamente contro i Lakers, perdendo il treno per le cinque stagioni a seguire, fino a quella del 1975/76.
La squadra è guidata in panchina da John MacLeod, ed appare ben strutturata per coralità, anche se non impressiona particolarmente durante la regular season. Conquistando i playoff con un record di poco sopra al 50% di vittorie (42-20) ed il terzo posto nella Pacific Division.
Il leader assoluto è Paul Westphal, una guardia tiratrice scelta dai Boston Celtics al Draft con la decima pick del 1972, proveniente da University of Southern California, e scambiato a Phoenix per Charlie Scott proprio nella offseason ‘75. Westy passa dal ruolo di comprimario in Massachusetts a stella assoluta in Arizona, imponendosi subito con 20.5 punti per gara. Accanto a lui, Alvan Adams, un rookie capace di produrne 19 per incontro, ed un gruppo profondo che comunque sostiene un sistema che potremmo definire democratico, dove si intravede anche l’ultimo Pat Riley in versione giocatore. Pur facendo capolino ad intermittenza dal fondo della panchina.
Certo, ai tempi si poteva partire direttamente dal secondo turno in base ai meriti conquistati durante la stagione, ma le semifinali di Conference contro i Seattle Supersonics non appaiono facili da superare, soprattutto partendo da una condizione di svantaggio del campo. Malgrado 45 punti di un clamoroso Fred “Downtown” Brown, in gara 2 Phoenix si impone in trasferta, impattando una serie che era iniziata con il piede sbagliato, per portarsi in vantaggio sul 3 a 1 al termine di gara 4 in casa. Con 39 punti di Westphal e 31 dalla panchina di un clamoroso Keith Erickson, altra ala piccola californiana a roster.
Superando l’ostacolo in sei sfide, la prima Conference Finals della franchigia diviene una battaglia contro i Golden State Warriors di Rick Barry, rincorrendosi fin dall’inizio per giungere ad una faticosa gara 7 in trasferta. Ancora una volta, con cinque giocatori in doppia cifra i ragazzi di MacLeod riescono ad imporsi in quello che potremmo definire un upset, considerando che gli avversari si presentavano forti del titolo di campioni in carica. Non una cosa da poco.
Si tratterà del primo viaggio in Finale di due, nella storia della franchigia, anche se l’ipotesi di imporsi appare remota, dovendo scontrarsi con i Boston Celtics di Dave Cowens, Jo Jo White ed un John Havlicek già trentacinquenne, ma ampiamente in grado di dominare il campo. Le prime due partite vengono risolte piuttosto agilmente dai padroni di casa al Garden, ma in gara 3 all’Arizona Veterans Memorial Coliseum, con la squadra di casa già con le spalle al muro serve una prova eroica per poter tenere la serie in piedi.
Alvan Adams decide così di vestire i panni dell’eroe, gli stessi che gli varranno il premio di Rookie of the Year dopo aver partecipato all’annuale partita delle stelle: per la power forward di 206 centimetri dal jumper pungente, ci sono 33 punti e 14 rimbalzi.
Ed i Suns riescono a sopravvivere, riequilibrando la sfida in gara 4, prima del pivotal game di Boston, ricordato da molti come “the greatest game ever”.
Il primo quarto suona come un massacro, con Phoenix costretta ad appena 18 punti totali a fronte di 36 degli avversari, riuscendo però a riavvicinarsi nel secondo tempo, rendendo letteralmente pan per focaccia costringendo i padroni di casa a 16 e 18 punti nella terza e quarta frazione. Insomma, dopo un avvio shock, Westphal e compagni alzano prepotentemente la difesa e superato il muro della soggezione (sul tetto del Garden sventolano già dodici vessilli di campioni) impattano la sfida sul 68 pari, favoriti dal parziale guidato dalla point guard Ricky Sobers.
Sotto di cinque punti con poco più di un minuto sul cronometro, Westphal prende la partita in mano portando i suoi in vantaggio di un punto, prima che uno spento Havlicek finisca in lunetta. Segna il primo, sbaglia il secondo, ma i suoi catturano il rimbalzo, senza riuscire a siglare il tiro decisivo. A questo punto, inizia a succedere di tutto: i secondi da giocare sarebbero quattro, ma sul tabellone ne viene sottratto uno. La rimessa di Phoenix viene intercettata, con Paul Silas che chiama un time out per la squadra di casa, senza averne diritto, venendo così graziato da un tecnico sacrosanto. Si vola così al primo supplementare, e come storia insegna, saranno ben tre.
La parità resta sostanziale fino alla cosa del secondo prolungamento, con Curtis Perry dei Suns che segna il canestro del più uno, prima di veder il solito Hondo depositare in fondo alla retina il tiro che vale il 110 a 111.
Tutto intorno è il delirio, e la partita sembra essere finita. Anzi, forse si prova a farla finire con un ennesimo espediente più che discutibile, perché sul cronometro di sarebbero ancora due secondi. Gli arbitri vengono ben consigliati, se ne accorgono, e permettono a Phoenix di riprendere il gioco. Nella confusione più assoluta, Westphal chiama un time out stavolta consapevole di non averne a disposizione, regalando il libero del tecnico del più 2 agli avversari, ma conquistando la possibilità di rimettere da centro campo.
Gar Heard riceve la palla, e davanti a 15.000 spettatori increduli realizza uno dei buzzer beater piuù incredibili di sempre, che vale il proseguimento di una gara apparentemente già finita. Niente da fare, poi, in estrema conclusione. E da una maratona simile i ragazzi dell’Arizona non si riprenderanno più, perdendo gara 6 in casa per 87 a 80, e con quella i sogni di gloria.
Per tornare a giocarsi il titolo di Conference non serviranno molti anni, appena due. Ancora una volta contro i Supersonics destinati all’anello, dopo aver perso il titolo l’anno precedente con i Bullets. Ancora guidati da Paul Westphal in campo, coadiuvato dall’ottimo Walter Davis , e con il solito MacLeod in panchina capace di condurre i suoi a 50 vittorie stagionali. Serviranno sette partite per gettare la spugna, con il rocambolesco rientro avversario di gara 6, vinta per appena un punto con le spalle al muro, ed il successo di Sonics nella gara/spareggio grazie a 33 punti e 11 rimbalzi di Jack Sikma.
Dopo essere passato proprio a Seattle in una stagione sfortunata, e poi a New York, Westphal torna a casa nella stagione 1983/84; la sua ultima in carriera come giocatore, rilegato al ruolo di comprimario da problemi fisici e dal raggiungimento dei 33 anni di età. I Suns sono un’altra squadra rispetto al passato, ma il manico in panchina resiste ed anche quella capacità di non darsi mai per vinti, anche qualificandosi dopo 41 vittorie e 41 sconfitte in stagione. Resiste ancora Alvan Adams, in quello che non è più il gruppo del solo Walter Davis, perché coadiuvato da un giovane Larry Nance già in grado di spostare volumi offensivi producendo plus difensivi di rilievo, ed il veterano Maurice Lucas.
Servono cinque gare al primo turno per disfarsi dei Blazers del rookie Clyde Drexler, e sei per sbarazzarsi dei Jazz di Adrian Dantley e Thurl Bailey. Poi, le Conference Finals contro i Lakers in piena era Showtime. Riusciranno a forzare altre sei partite, contro Magic, Kareem, Cooper. Wilkes, Scott, Worthy e McAdoo.
Quasi un’impresa a ripensarci, ma insufficiente per tornare a giocarsi quel titolo lasciato probabilmente al Boston Garden, dopo l’incredibile gara 5 del 1976.
Da Chambers e KJ, passando per Sir Charles
Saranno necessari tre anni di oblio, a seguito di una eliminazione al primo turno, prima di tornar a riveder la luce. In panchina si siede il pittoresco Cotton Fitzimmons, da Cleveland arriva una point guard che risponde al nome di Kevin Johnson (chiuso a roster da Mark Price e quindi ceduto), da Seattle un attaccante purosangue come Tom Chambers. La grazia di un airone con la grinta del più scorretto ed ingestibile dei caratteri. Tra l’altro, approda in Arizona come primo Unrestricted Free Agent di sempre, inventando più o meno direttamente un trend.
Già MVP dell’All Stars Game del 1987, il (mai) buon Tom si sentiva piuttosto limitato nel roster dei Sonics, che pullulava di pari ruolo, in un’epoca in cui potevi rinegoziare il contratto con la squadra che ti aveva scelto al Draft, potendo muoverti solo da pedina di scambio, accettando magari destinazioni poco stimolanti.
Un pericolo che Chambers sentiva crescere di giorno in giorno, ed appariva sostanzialmente inevitabile, fino alla chiamata di Larry Fleischer. Uno dei fondatori dell’NBPA ancora ben attivo nel sindacato.
Conosciuti i malumori della stella di Seattle, Fleicsher consigliò a Chambers di prendere tempo rispetto all’offerta di rinegoziazione, perché qualcosa stava cambiando in quei giorni, a livello di garanzie contrattuali in un tira e molla tra lega e sindacato.
Poche settimane dopo infatti, si raggiunge un accordo di revisione del contratto collettivo, concedendo un diritto al libero arbitrio illimitato per i giocatori considerati “veterani”. Significava, in buona sostanza, che chiunque avesse giocato almeno sette stagioni da professionista, firmando almeno due contratti in quell’arco temporale, avrebbe potuto non rinegoziare con la sua squadra e mettersi autonomamente nel mercato.
Libero di scegliere in base alla destinazione oppure all’offerta più vantaggiosa, preferibilmente in base ad entrambe. Così Tom Chambers – che aveva tutti i requisiti in regola per farlo – diviene il primo Unrestricted Free Agent della storia, accasandosi a Phoenix forte anche del contratto da nove milioni offerto dai Suns.
Non esattamente una cifra da capogiro ai livelli moderni, ma indubbiamente superiore a quella che avrebbe percepito ai Sonics, obbligato dalle circostanze.
Guidati anche e soprattutto da lui, i Suns in finale di Conference ci arriveranno per due anni consecutivi, uscendo con un secco sweep ancora contro i Lakers proprio nell’89, per replicare l’anno seguente. Stavolta contro i Blazers in sei sfide, dopo aver servito la vendetta ai gialloviola in occasione del secondo turno.
KJ si sta già imponendo tra i migliori nel ruolo della lega, viaggiando serenamente sopra i 20 punti e i 10 assist per gara, mentre emerge anche il grintoso “Thunder” Dan Majerle, all’interno di un gruppo che va plasmandosi di stagione in stagione, vincendo tanto in regular season ma dando la sensazione di essere ad una pedina dall’ultimo atto. Quella pedina – piuttosto ingombrante per status e stazza – stava per arrivare nell’estate del 1992, in piena prima era di dominio Bulls.
La stagione 1992/93 è quella in cui Fitzimmons decide di farsi da parte, diventando General Manager e lasciando la panchina ad un esordiente, già ben conosciuto nell’ambiente. Proprio quel Paul Westphal che le Finals con i Suns le aveva giocate – le uniche – giungendo più vicino all’impresa di quel che si poteva ricordare. Charles Barkley, invece, è reduce dal clamoroso successo del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona, dove ha recitato il ruolo di croce e delizia per i selezionatori della squadra più forte mai assemblata per un torneo cestistico.
Tra gomitate agli angolani, notti brave per le Ramblas, schiacciate e rimbalzi che gli valgono il premio di migliore della competizione, Sir Charles riesce addirittura a farsi finalmente cedere dalla squadra che lo aveva selezionato nel Draft del 1984, con la quale era ai ferri corti già da tempo. I Philadelphia 76ers.
A roster, Chambers accetta di buon grado di recitar la parte del veterano nelle retrovie, sostenuto dall’arrivo di Danny Ainge, altro uomo di assoluta esperienza e non certo conosciuto come agnellino in campo.
Il rookie che desta sensazione è Richard Dumas, selezionato nel 1991 ma subito squalificato dalla lega per abuso di sostanze, e per questo riemerso dopo un anno di purgatorio all’Hapoel Holon. Chiuderà la sua prima stagione con 15.8 punti di media.
La coscienza della squadra è affidata ad un Kevin Johnson che accetta (non senza malumori che emergeranno alla lunga) di esser meno accentratore offensivo, limitando ai momenti decisivi il suo talento in penetrazione, a vantaggio di un Barkley che vincerà meritatamente il premio di MVP stagionale.
L’uomo dei parziali a vantaggio resta il granitico Majerle, capace di sputar sangue in difesa tanto quanto decidere le sfide con capacità balistiche al tempo impressionanti.
Dalla panchina, fiorisce anche Cedric Ceballos, ed esistono speranze concrete di trasformare il talento dell’altro rookie Oliver Miller in un qualcosa di importante per il domani. Peccato che preferirà sempre più aumentar di peso in modo impressionante, che applicarsi appoggiando una mano educatissima al tiro.
Insomma, tutto questo va saputo gestire in modo intelligente, e Westphal si rivela la chiave per il successo di squadra, allenandola con serenità, offrendo momenti di svago, trasformandoli in una gioiosa macchina da guerra bellissima da guardare. In stagione vincono 62 volte conquistando il miglior record della lega. In postseason soffrono i giovani Lakers al primo turno, superandoli in cinque gare, prima di aver la meglio degli Spurs di David Robinson in sei sfide. Tra l’altro grazie ad un canestro stratosferico di Barkley proprio in faccia all’Ammiraglio, nell’azione decisiva. 28 punti e 21 rimbalzi per lui, numeri che in un campionato simile appaiono quasi ordinaria amministrazione.
Tornati alle finali di Conference, la storia incrocia di nuovo Phoenix con Seattle, stavolta guidata dal giovane dynamic duo formato da Gary Payton e Shawn Kemp, con George Karl in panchina. Un altro che abbraccia la filosofia Westphal di gestione dello spogliatoio, magari in modo meno gioioso, trovandosi per le mani un’autentica polveriera che sarebbe esplosa a playoff nelle edizioni a seguire. Servono sette partite, con Barkley che chiude i giochi davanti al pubblico dell’American West Arena, migliorando il suo rendimento rispetto all’ultima sfida della serie precedente: i punti sono 44, i rimbalzi 24.
Westphal riporta i Phoenix Suns in finale, giocando stavolta un altro ruolo, quello del timoniere.
All’inizio, la prospettiva di affrontare una versione dei Bulls sfiancata da polemiche e pressioni, regala addirittura qualche speranza, immediatamente sopita da una serie in cui Michael Jordan viaggerà su medie spaventose, con 41 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e quasi 2 recuperi di media.
I Suns riusciranno a rientrare vincendo una clamorosa gara 3 al Chicago Stadium, dopo due sconfitte casalinghe e tenendo duro dopo tre tempi supplementari. Una cosa che ricorda molto l’impresa che Westphal aveva condotto dal campo.
Forzeranno il ritorno in Arizona per gara 6, dopo esser riusciti a strappare un ennesimo successo ancora in trasferta, prima di venir freddati da una tripla quasi allo scadere di John Paxson che consegna il primo three-peat dei nineties a Jordan e compagni. Con il ritiro di quest’ultimo però, malgrado le aspettative e le grandi mosse di mercato, nei due anni a seguire Phoenix dovrà accontentarsi sempre di uno stop alle semifinali di Conference.
Entrambe le volte contro gli Houston Rockets, sempre dopo sette sfide, l’ultima delle quali decisa dal famoso “bacio della morte” di Mario Elie, a cancellare i 46 punti e 10 assist di uno stoico KJ.
Dal seven seconds or less ad oggi
A partire da questo punto della storia, non è che davanti ai Suns si materializzi un precipizio vertiginoso fatto di delusioni e senza fondo apparente. Anzi, tutt’altro. Per un Barkley vittima di problemi fisici che minaccia il ritiro a fine di ogni stagione (finendo infine a Houston accanto a Drexler e Olajuwon), dal Draft arrivano giocatori come Michael Finley, Antonio McDyess, Shawn Marion. Talenti come Jason Kidd, Sam Cassell, Danny Manning, Robert Horry, Rex Chapman, Tom Gugliotta, Anfernee Hardaway, Stephon Marbury.
Arriveranno anche le qualificazioni playoff, molto spesso terminate dopo il primo turno, per problemi di chimica e molto spesso di infortuni.
Con la nona scelta nel Draft del 2002 giunge, direttamente dalla High School, il centro Amar’e Stoudamire. Un concentrato di potenza ed agilità destinato a sbocciare senza ombra di dubbio. Ed infatti vince subito il premio di Rookie of the Year, tanto per gradire. Nel frattempo, dopo l’arrivo in corsa in panchina di Mike D’Antoni, nella offseason del 2004 ritorna un giocatore originariamente scelto dalla franchigia nel Draft del 1996, ma troppo presto spedito a Dallas, per mancanza di spazio. Quell’uomo risponde al nome di Steve Nash, e con l’aiuto dei due sopracitati non solo riporterà i Suns in alto, ma con le sue intuizioni geniali ed il suo talento assoluto, permetterà loro di trasformarsi nella squadra più divertente da vedere nella lega.
Una di quelle generazionali, grazie alla quale in molti ancora oggi – anche a queste latitudini – tifano per la franchigia dell’Arizona. Quella del “seven seconds or less”, il tempo massimo ideale per concludere un’azione offensiva. Impostando il gioco sul dinamismo, la rapidità e la vivacità.
Al primo anno della triade (per la verità, Shawn Marion gioca un ruolo chiave nel sistema di squadra), tra i ragazzi di D’Antoni e le Finals si contrappongono solo gli Spurs, che li eliminano in cinque partite prima di sudarne sette per battere i Pistons e laurearsi campioni. Nell’edizione del 2006 invece, tocca soccombere contro i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki, destinati ad esser superati dai Miami Heat di Wade e Shaq.
Per due anni consecutivi con un record complessivo di 116 vittorie e 48 sconfitte in regular season, Phoenix è costretta ad uscire per mano dei futuri campioni NBA prima, e contro il gruppo che Nash aveva contribuito a costruire prima del suo ritorno. Sulla carta non certo superiore. In quelli a seguire, dovranno piegarsi sempre e comunque alla bestia nera rappresentata da San Antonio, capace di inficiare campionati giocati a ritmi serrati, alto livello, con grandi risultati raggiunti per altrettante gigantesche delusioni.
Mike D’Antoni vincerà un premio di Coach of The Year nel 2005, stesso anno in cui Steve Nash si laureerà MVP per la prima volta. La seconda, la stagione seguente. Ma non basta. I Suns non riescono a raggiungere i playoff malgrado le 46 vittorie nella stagione 2008/09, per ritornare in grandissimo spolvero il campionato seguente. Quasi fosse un’ultima danza, o quasi.
D’Antoni si è già accasato in altri lidi, a vantaggio sostanzialmente di Alvin Gentry, mentre Steve Kerr (uno che ai Suns aveva giocato, iniziando in Arizona una carriera già sviluppatasi al College, stesso Stato) ricopre il ruolo di Executive.
Dietro alla coppia formata da Nash e Stoudamire, c’è un veterano di cristallo come Grant Hill, Jason Richardson, Leandro Barbosa ed un giovane Goran Dragić. Dopo 54 vittorie stagionali eliminano Portland e (finalmente) San Antonio nei primi due turni, prima di trovare in finale di Conference un Kobe Bryant determinato a vendicare la sconfitta subita con i Boston Celtics due anni prima. Nash ha 35 anni, e riesce comunque a guidare i suoi mantenendosi sui 17 punti e 11.8 assist nella serie, ma contro i Lakers del Mamba tocca ancora una volta sventolar bandiera bianca.
Stavolta l’oblio è seriamente dietro l’angolo, e per tornare a parlare di postseason (attenzione, non di Conference Finals ma semplicemente di qualificazione) serviranno 11 anni. La ricorsa per il play-in in occasione della Bubble di Orlando, vanificata ancora una volta al fotofinish, restituisce un’immagine di Phoenix che sembrava plasmarsi nel tempo, ma non troppo percepita dai più.
In panchina è arrivato un coach come Monty Williams, a coronare un progetto che punta nella ricostruzione della cosiddetta “culture”, partendo dalle strutture di allenamento, il coaching staff e le scelte a disposizione nei Draft. Come ben sappiamo, negli anni sono giunti talenti cristallini come Devin Booker e più discutibili come DeAndre Ayton, ma anche una serie di apparenti specialisti capaci di salir di colpi sotto la guida cosciente di Williams, come Mikal Bridges, Cameron Johnson, Dario Sarić.
Il modo per provare a trasformare una buona squadra (si, perché nella rincorsa della bolla quei Suns vincono 8 partite senza perdere mai, non agganciando per un soffio la chance di restare in gioco) in un gruppo da secondo miglior record NBA, risponde al nome di Christopher Emmanuel Paul. Guida spirituale, tecnica ed esperienziale.
Uomo in missione se poteva essercene uno, pronto a disputare nuovamente una Conference Finals, riportando Phoenix laddove in pochi, probabilmente, la avrebbero pronosticata meno di 12 mesi fa.
Proverbiale luce in fondo ad un tunnel lunghissimo, per un palcoscenico dal quale la franchigia manca veramente da troppo tempo. Sperando che non finisca qui, ovviamente.
Anche se l’amuleto che ha condotto i Suns in finale, in duplice veste nei due unici viaggi ad oggi, non potrà seguirli in nessun ruolo e neanche dalla stessa dimensione. Paul Westphal – Hall of Famer classe 2019 – si è spento in avvio di 2021, il 2 di gennaio, dopo aver combattuto invano contro un tumore al cervello diagnosticato nell’agosto precedente. Aveva compiuto appena 70 anni d’età.













































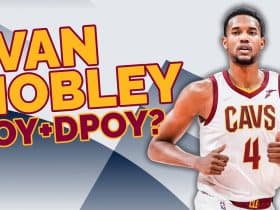



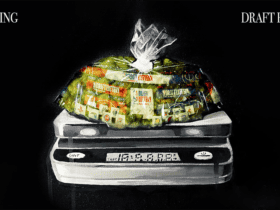











Lascia un Commento
Mostra i commenti