Bentrovati a tutti lettori di TrueShooting! Come ve la passate? Noi non troppo male (per i nostri bassissimi standard) stranamente, e questo soprattutto perché, dopo mesi di progettazione e ripetute procrastinazioni, siamo finalmente pronti a presentarvi “The Grantland Tribute”, il nuovo appuntamento a cadenza rapsodico-randomica del vostro sito a tema cestistico preferito.
“Ma cos’è ‘sta roba?’” vi chiederete voi, giustamente. Ecco, “TGT” (pessimo acronimo, ne conveniamo) è, appunto, una rubrica ideata da due velleitari autori e una prode grafica con l’intento di omaggiare, per quanto possibile, il ricordo di un blog che ha fatto la storia del mondo sportivo a stelle e strisce.
Per i pochi miscredenti che non lo conoscessero: Grantland fu un sito fondato dal benamato Bill Simmons, che racchiudeva al suo interno tantissimi fra i migliori autori che ora leggiamo fra più disparati siti (da Zach Lowe a Dave Schilling e via andando). La grande particolarità di questo capolavoro digitale era però principalmente nel taglio giornalistico, che dava possibilità di spaziare da argomenti strettamente tecnico-sportivi a temi di pop-culture, spesso unendoli insieme con clamorosa nonchalance.
Per volerci subito accostare al’ambito di questo primo pezzo, possiamo serenamente dire che abbiamo voluto metaforicamente “morire come uomini che hanno sfidato gli dei” con questa idea. Consapevoli di questo abbiamo però comunque deciso di darla alla luce, essendo per noi profondamente personale, considerato l’impatto che Grantland ha avuto sulla nostra crescita come appassionati.
I temi degli articoli saranno dunque molto variabili, con l’unico vincolo – ossimorico a dire il vero – di una totale libertà auto-impostaci sul come trattarli, sia dal punto di vista grafico che contenutistico.
Come punto di inizio ci eravamo posti l’idea di un articolo molto complesso e pieno di lungaggini su un interessante tema trasversale, ma è fine settembre, nessuno ha voglia di leggerlo e tantomeno noi di scriverlo, perché quindi non buttarsi su un pezzo dallo stampo musicale, magari sfruttando l’onda lunga (ormai nemmeno troppo) del draft NBA?
Oggi vi presentiamo dunque 10 prime scelte molto diverse fra loro, alcune molto rock, altre puramente hip hop, e a ognuna di esse andremo ad associare, arbitrariamente, un album del genere che più vediamo adatto, che ci si ricolleghi per qualche ragione, o che anche solo ci piaccia accostare a quel determinato giocatore, con un piccolo bonus finale per colui-che-non-può-essere-paragonato.
Chris Webber – Smashing Pumpkins – Mellon Collie and the Infinite Sadness
La carriera di Chris Webber può essere serenamente definita – per molti tratti – agonica e decadente, senza intendere con questi termini alcun tipo di offesa. Nel 1995 Billy Corgan, un vero e proprio pioniere della musica, nasconde, dietro al refrain magnetico di “Bullet with Butterfly Wings”, uno dei dischi più romantici e variegati della storia del Rock, una sorta di summa di tutto ciò che questo genere aveva offerto nei 35 anni precedenti. Dal punto di vista tecnico Webber si avvicina molto a questa visione, stiamo infatti parlando di un lungo che, almeno offensivamente, riesce a combinare ogni movimento creato e perfezionato nella storia NBA, accentrando in sé quasi tutte le caratteristiche che si possano avere: dalla potenza dei primi anni alla finezza quasi poetica della parentesi, “sfortunatamente”, perdente di Sacramento. Un vero e proprio trattato sul ruolo del lungo e la sua evoluzione.
Webber era poi soprattutto un genio triste, a cui forse, come a Corgan, è sempre mancato il senso del concreto ma che, quando lasciato libero di creare e spaziare con la propria fantasia, era in grado di tirare fuori capolavori assoluti. Malinconia e teatralità, i tratti d’unione di questo disco e della parabola di Chris, che spazia dalle arie più rarefatte ai fossi del mondo NBA, sempre mantenendo però quel pizzico di stile, quella sorta di distacco nobiliare che un giocatore così complesso e variegato non può che lasciar trapelare, volente o nolente.
Abbagliati dalle schiacciate della gioventù ci siamo invece ritrovati con uno dei lunghi più eleganti e tecnici che il gioco ricordi.
Il parallelo fra questi due personaggi è dunque quasi inevitabile e indissolubilmente legato al fascino che certe personalità non possono che esercitare verso il pubblico, specie quello più raffinato e colto. Artisti elitari per definizione, perché, in fondo, non tutte le opere necessitano di essere immediatamente comprese da tutti.
Yao Ming – Voodoo – D’Angelo
Quando ho iniziato a pensare alla mia parte in questo articolo, il paragone tra Ming e il capolavoro di D’Angelo è stato il primo a cui ho pensato e più lo esploravo, più acquisiva senso ai miei occhi.
In primo luogo per le due figure che, per quanto agli opposti dello spettro umano, sono caratterizzate da un fascino simile, un senso di indefinito che le avvolge e che fa pensare – indipendentemente da quanto le si possa studiare – che ci sarà sempre qualcosa di non detto, qualcosa che sfugge. Di questo alone, la vita cinese del primo e i lunghi periodi tra un lavoro e l’altro del secondo (caratterizzati da periodi di blocco e sessioni di registrazione tranquillamente definibili leggendarie), compongono solo lo strato più superficiale.
Ma c’è di più. C’è la dimensione di chi non solo è diventato una leggenda nel proprio campo, ma lo ha fatto in modo estremamente riconoscibile, combinando il proprio talento naturale e la pratica come nessuno aveva mai fatto prima e come nessuno riuscirà a fare successivamente.
Yao Ming è Yao Ming. Non ci sarà un altro centro di 228 cm di un paese “inesplorato” con quelle capacità atletiche, quella maestria tecnica e quella personalità attraente.
Allo stesso modo, D’Angelo è D’Angelo, e Voodoo ne è la prova più brillante. Un artista dal talento naturale straordinario e coltivato fin da subito (inizia a studiare pianoforte a 3 anni), un album capace di combinare secoli di musica black e sonorità da inizi 2000 in modo tale che l’etichetta di Neo-Soul gli si cuce con tale precisione da diventare quasi stretta.
E poi c’è la musica. Divertente e melliflua ma con una “spessa” linea di basso persistente che ancora il brano e gli dà sostanza. Perfetta per un giocatore che, tra mille evoluzioni sul piede perno e una delicatezza generale, ha comunque bullizzato – in attacco e/o in difesa – sostanzialmente qualunque All-Star abbia provato a marcarlo.
Una bellissima coreografia per ballare Devil’s Pie:
Tim Duncan – Ok Computer – Radiohead
Nel 1997 i Radiohead stanno concludendo i lavori sul loro ultimo album, destinato a sconvolgere, oltre che l’intera scena musicale, anche la concezione che della band si era avuta fino a quel momento. Nel 1997 viene chiamato, con la prima scelta assoluta, un giocatore destinato a diventare il simbolo dell’essere granitico e solido, il pilastro di una dinastia sempre fedele a se stessa, sempre basata su quei due assiomi fondamentali, Duncan e Pop, Pop e Duncan.
Una legacy quasi claustrofobica, racchiusa in questi due nomi, come opprimente è Paranoid Android, eppure così sperimentale, perché da questo disco i Radiohead usciranno come gli innovatori che in realtà sono sempre stati, liberandosi dello stigma di cantanti pop, esattamente come gli Spurs sono riusciti a passare dall’essere gli emblemi del tradizionalismo più reazionario, all’inventare il basket moderno nella sua nuova sostanza, con la squadra 2012-2014.
Perché alla fine è impossibile scindere Duncan dagli Spurs, ed è impossibile parlare dei Radiohead senza questo disco che, esattamente come Timmy, mi ha sempre dato una sensazione di straniamento molto forte, un giocatore così straordinario, sicuramente uno dei migliori 5/6 di sempre, eppure così poco riconosciuto, così poco affine ai canoni della star che tanto ci vengono costantemente sbandierati e pubblicizzati.
È un parallelo molto personale questo che sto trovando, lo so, ma le sensazioni che mi hanno dato sono sempre state molto simili, impressioni di un qualcosa di peculiare, difficilmente spiegabile con la scala di valori comunemente usata, perché un brano come “Electioneering” non si era mai sentito e uno al livello di Duncan fin dal primo anno non c’era mai stato, perché è però anche è vero che “No surprises” è la “Sunday morning” degli anni 90, come Duncan è il Bill Russell della mia generazione. Tutto e il contrario di tutto.
Quando osservi la dinastia degli Spurs dall’esterno, la sensazione è e rimane comunque quella di essere un turista in visita, che magari può coglierne o copiarne una parte, ma che sicuramente non sarà mai in grado di comprenderne appieno il senso.
Tim Duncan (21 PTS, 20 REB, 10 AST, 8 BLK) delivered an iconic performance to close out the Finals 😱
— NBA TV (@NBATV) November 11, 2020
Spurs vs. Nets, 2003 NBA Finals Game 6 – 10am ET on NBA TV! pic.twitter.com/wJvgPNrEtx
Karl-Anthony Towns – The Divine Feminine – Mac Miller
Il paragone tra i due viene abbastanza naturale, e non solo perché i due erano grandi amici.
Karl-Anthony Towns è un giocatore che dovevamo ancora vedere, potrebbe essere il calco di ciò che vedremo normalmente in un futuro più o meno prossimo o rivelarsi qualcosa che passa solo quando un’entità sovrumana (quella a cui più credete) decide di combinare un corpo straordinario a capacità estremamente insolite, producendo qualcosa di bellissimo.
Credo che Mac possa essere analizzato allo stesso modo. È indubbio che sia qualcosa di attualmente unico, un contributo che ha decisamente allargato i confini dell’hip hop, un punto di vista al momento unico (che non voglio definire “unico rapper bianco non arrabbiato” ma è effettivamente il punto di partenza), ma che, come per il gioco di KAT, potrebbe costituire la blueprint di qualcosa che vedremo sempre più spesso.
Dal punto di vista strettamente “tecnico”, credo che gioco e musica si combinino perfettamente.
Entrambi estremamente fluidi, creativi, “smooth”, “chill”. Il basket esce dalle mani di KAT con la stessa naturalezza con la quale i flow si producono nella testa di Mac.
Davvero, non ho paragoni migliori per descrivere le sensazioni che dà vedere un centro “vero” giocare in quel modo sul perimetro se non con l’abilità di scrivere canzoni rap d’amore perfette, hanno la stessa componente di improbabilità e condividono un elemento “massiccio” che pure si produce in forme eteree.
Insomma, la voglia di andare al campetto che viene guardando giocare KAT è esattamente la stessa voglia di correre dietro la propria crush sotto la pioggia e finire la serata a fare bambini ogni volta che parte una tromba o un sax in The Divine Feminine (cioè in quasi ogni momento dell’album).
Kyrie Irving – Pink Floyd – The Dark Side of the Moon
L’abbiamo visto in tutte le salse, dalle magliette di qualche adolescente ai murales di tutto il mondo, quel cristallo che devia la luce e la trasforma in arcobaleno. Dovrebbe bastare questo per capire quanto questo disco sia uno dei più inflazionati capolavori assoluti della storia della musica rock.
E Kyrie Irving è un prodigio troppo discusso nello stesso modo in cui lo è questo disco, e, esattamente come questo disco, se ne parla troppo – spesso a sproposito – come icona e poco dal punto di vista tecnico, quando forse sarebbe meglio invece concentrarsi sul secondo che, al di là di ogni ragionevole dubbio, risulta tremendo e cinico nella sua perfezione.
Forse il giocatore più tecnicamente dotato a livello di scoring della storia del gioco (e no, non sto facendo assolutamente un’iperbole) ma soprattutto davvero l’altra faccia della luna, nell’occhio del ciclone nel suo essere perpetuamente scrutinata alla ricerca di qualche imperfezione che ci faccia sentire più sicuri, perché la faccia visibile, quella di tutti i giorni, è molto più rassicurante. Kyrie ci mette di fronte al nostro conformismo, al nostro volere che tutti gli atleti che osanniamo siano – per nostra arbitraria scelta – simili fra loro, che si attengano a dei canoni e che dunque quello diverso sia una sorta di squilibrato da schernire.
Kyrie è nato Uncle Drew per la Pepsi ma è cresciuto come molti non sono mai riusciti a fare, ed è oggi uno degli atleti più socialmente consapevoli del mondo americano, non allineato, odiato e sicuramente divisivo e controverso, perlomeno per chi di coscienza sociale ed etica ne ha davvero molta poca.
Ma quanti giocatori vi ricordate fare quello che ha fatto lui a livello di Finals, specie con un ruolo da “secondo” violino? 1/2 al massimo, e già siamo su stime ottimiste. Ecco, forse sarebbe il caso di parlare più di questo, di quanto la sua mera presenza sia un condizionamento enorme per ogni difesa che si trova di fronte, delle sensazione di terrore che non può che pervadere ogni difensore che si trovi sull’isola contro di lui.
E poi sì, perché no, magari anche smetterla di dividere il mondo in “Us and Them”.
5 years later, still one of the best one-on-one basket I have ever seen, the fact that he even got a shot off, after almost falling two times, is unbelievable. Also considering perfect defense, moment and leverage of the game pic.twitter.com/qZJE7usfFK
— Leonardo Pedersoli (@LeoPedersoli) March 17, 2021
Ben Simmons – 2014 Forest Hill Drive – J. Cole
Un legame fondato non solo sulle qualità che caratterizzano i due talenti, ma anche e soprattutto sui problemi e sulle critiche che ne connotano profondamente le figure.
Simmons, un giocatore con tonnellate di talento naturale, capace di muoversi per il campo come se gravitasse su un piano diverso dagli altri, con tempi dilatati che gli permettono di vedere cose e muoversi con lo swag di chi ha già previsto cosa sta per succedere. Giocatore completo, non c’è niente che non possa fare (ok, una cosa a quanto pare la può fare solo nei video che posta su Instagram ogni estate, siamo d’accordo) e in alcune cose è in una cerchia molto ristretta dei migliori NBA.
J. Cole dal canto suo è un rapper estremamente dotato, una penna raffinata che sembra avere barre pronte per ogni ora del giorno, 24/24, 7/7. Si è preso, con legittime ambizioni, almeno il 50% del titolo di miglior conscious rapper di questa generazione (l’altro 50, almeno l’altro 50, spetta ovviamente a Kendrick Lamar), ma ha anche toccato e giocato con ogni altro registro, lirico e musicale, che il rap ha da offrire (trovando difficoltà andando verso l’alta intensità e le tracce più aggressive, curiosamente un difetto in comune con Simmons, che fatica a mantenere con costanza una fase offensiva aggressiva). In aggiunta a tutto questo, è un producer di riconosciuta qualità. Pacchetto completo.
Parlando dei difetti, credo siano talmente riconosciuti e discussi che diventa superfluo affrontarli in profondità. Da una parte il rifiuto patologico (e che a ben guardare sembra peggiorare di anno in anno) di prendere tiri che non siano a distanza di centimetri dal ferro e la mancanza di aggressività generale in attacco, le accuse di fare lavori “noiosi” dall’altro.
Sono entrambe accuse estremamente superficiali nel senso letterale del termine, molto facili da sostenere e che vengono mitigate dai fan disposti ad approfondirle a più livelli (ma che sono costretti a riconoscere, in quanto verità abbastanza evidenti).
In particolare, 2014 Forest Hill Drive è un lavoro che potrebbe avere alla base un mindset molto simile a quello dell’attuale Simmons.
È un lavoro che vuole dichiaratamente essere il classico (basta ascoltare Note to Self, 14 minuti di classico monologo in salsa ROC, che prende spunti dal discorso per l’oscar di Gooding Jr. e ci mette anche un po’ di Fugees nell’outro, in caso i riferimenti mitici non fossero abbastanza), il lavoro che definisce la caratura di J. Cole: 13 brani, un’ora e quattro minuti di J. Cole e J. Cole soltanto (nessun feat), prodotto da J. Cole.
Un lavoro mastodontico che, come ogni capolavoro del rap, vuole prendere ogni fase saliente nella vita dell’artista e reinterpretarla artisticamente in una chiave universale che faccia ballare, commuovere, pensare ogni suo ascoltatore. Un lavoro da manuale.
In alcuni punti sembra perfino riuscirci, ma è nei punti in cui non lo fa che tutte le critiche mosse a Jermaine nel corso degli anni emergono con una prepotenza sensazionale.
Credo si rifletta molto bene con la carriera di un ragazzo fin da sempre convinto del proprio talento, al punto di non dover necessariamente raffinarlo troppo, con delle qualità che nelle situazioni più importanti possono tanto elevarlo su tutti gli altri, quanto mettere più in luce che mai dei limiti pesantissimi che rischiano di comprometterne seriamente la legacy.
https://t.co/St21VPJBJC pic.twitter.com/TDwmX6NRfz
— Cesare Russo (@caesarsalad7_4) August 3, 2021













































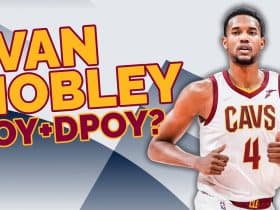



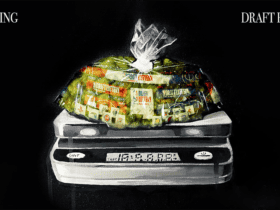








Lascia un Commento
Mostra i commenti