Larry Johnson – Appetite for destruction – Guns N’ Roses
L’esordio dei Guns N’ Roses è forse uno dei più dirompenti della storia della musica in senso ampio, non tanto per la qualità intrinsecamente artistica dell’album, sulla quale qualcuno potrebbe avere da ridire, quanto per lo stile, derivativo ma di indubbio impatto, che rimane iconico ancora oggi che faticano a esibirsi in pubblico.
Quando Larry Johnson è entrato nella lega, questa impressione che la distruzione fosse arrivata non l’hanno avuta in pochi, un corpo tremendo posto al servizio di una cattiveria agonistica e una spregiudicatezza raramente viste.
Come tanti gruppi anni 90 i nostri amati GNR hanno avuto vari momenti no all’interno della carriera, ma nessuno potrà mai dimenticare la prima volta che ha sentito “Paradise City” o “Sweet Child O’ Mine”, così come sarà difficile per gli avversari scordarsi il primo incontro con quella bestia di nome LJ, la prima volta che si son visti mandare in prima fila da una spallata in post basso o che hanno perso nel centro della schiena quel monolite semi-indistruttibile.
Il kilt e le mutande di Axl Rose come la pubblicità vestito da vecchietta di Larry, perché spesso chi vuole mostrare la faccia cattiva è invece molto ironico e abilmente in grado di mascherarsi.
I Knicks di Patrick Riley, i litigi con Mourning, rivalità con Miami, Van Gundy spettinato e trascinato per il campo, i rapporti, diciamo, ondivaghi fuori dal campo.
Sì, con Larry Johnson era davvero “Welcome to the Jungle”.
Derrick Rose – King’s Disease II – Nas
In realtà, quest’articolo sarebbe dovuto uscire molto prima.
Il problema è che un talento come il mio è soggetto a numerose altalene emotive, alti con un’enorme quantità di scrittura a un livello incredibile e bassi fatti di vuoto creativo e pigrizia (tanta pigrizia, tantissima) che mi sento di condannare ma allo stesso tempo di abbracciare.
Troppo? Va bene, troppo (per adesso). La parte sulla pigrizia è vera però.
Nel male della mia pigrizia c’è stato però un risvolto positivo: ho avuto il tempo di ascoltare King’s Disease II, uscito pochi giorni fa, e ho trovato l’ultimo pezzo dell’articolo.
Partiamo dall’ovvio per chi conosce entrambi gli uomini in questione.
Alla base c’è l’insormontabile difficoltà di tornare a delle altezze toccate, vissute e per qualche motivo perdute. L’MVP del 2011 e Ilmatic, il più giovane MVP di sempre e un album di debutto talmente clamoroso da poter essere considerato il miglior album di sempre.
Sono punte a cui il 99.9 (con molti 9)% dei giocatori di basket e dei rapper non si avvicinerà neanche da poterli scorgere con un binocolo accuratissimo nelle giornate con l’aria più pulita del mondo. Qui abbiamo invece due individui che le hanno raggiunte subito, al primo passo, per poi perderle per sempre al secondo e per i successivi anni di carriera.
Arriviamo al presente: Rose ha firmato un nuovo contratto con i Knicks dopo un’ottima stagione al MSG.
Non è il contratto faraonico di un MVP, ma è il primo contratto pluriennale dagli anni di Chicago per un giocatore che ha vissuto ogni fase di una carriera NBA, più di quanto i 33 anni possano far presagire.
Nas a 43 anni ha pubblicato un album, non il nuovo capolavoro della penna che ha scritto “N.Y. State of Mind” o “If I Ruled the World”, ma un buon lavoro per un rapper che dopo 27 anni di una carriera decisamente produttiva ha ancora qualcosa da dire e riesce a dirlo con invidiabile qualità.
In entrambi i casi ci sono delle anomalie: entrambi i giocatori sono consapevoli di essere fuori dal contesto generale, Rose non gioca come un cestista NBA del 2021, Nas non rappa come un rapper del 2021, pur riuscendo entrambi a ritagliarsi uno spazio in cui giocare secondo le proprie regole.
Ancora di più, in ogni partita Rose fa almeno una giocata in cui emerge l’MVP, un talento che merita molto più dei 13 milioni stagionali e che continuerà a sbocciare in singole giocate estemporanee fin quando Rose avrà la forza di muoversi con una palla da basket in mano.
Allo stesso modo, per quanto possa essere mediocre il disco, nel 2021 non puoi avere il feat di quella Ms. Lauryn Hill se non sei stato il re della mecca mondiale del rap, anche solo per un anno.
Anthony Davis – The Velvet Underground – White Light/White Heat
Forse il più grande talento della storia NBA. Forse la più grande band della storia della musica rock. Uno stile di gioco difficile da commentare, anticlimatico, che innervosisce e frustra chi lo osserva, che pare svilire e quasi offendere il suo talento. Un disco registrato in modo ignobile, inascoltabile a tratti, in cui gli strumenti si mischiano e il suono è incomprensibile, un grande tappeto ovattato non degno dei suoi autori.
Eppure stiamo parlando di due perle uniche nella storia, perché per quanto tu ti possa sforzare a far venire una cosa nel peggior modo possibile, il talento non può essere cancellato e offuscato da una semplice sfregio posticcio, un diamante è e rimarrà sempre un diamante, anche incastonato nel peggior anello del mondo.
Abbaglianti, i lampi di Anthony Davis ti fanno pensare a cosa sarebbe se solo cambiasse, un minimo, modo di giocare; abbaglianti come i suoni di Reed e Cale, che lasciano intravedere quello che il mondo avrebbe potuto godere senza una serie di vicissitudini, rifiuti e studi di produzione discutibili.
Ma alla fine è anche giusto così, il senso dell’incompiuto, di ciò che sarebbe-potuto-essere è quello che rende memorabili alcune opere, e diventa difficile anche immaginarseli diversi da così, forse perché ci siamo affezionati, o forse perché il come dovrebbe essere è spesso più interessante del come è.
Non è sempre però necessario sovrapporre la nostra visione alla realtà concreta, ogni tanto basterebbe apprezzare quello che vediamo. E quello che vediamo è che Anthony Davis è uno dei migliori giocatori degli ultimi 20 anni, un atleta semplicemente rivoluzionario, in grado di impattare il gioco in modi non immediatamente visibili, ma nondimeno incredibili, forse superiori a quelli di chiunque altro: riprendendo la frase di un mio caro e greco amico: “è talmente il migliore come secondo da essere il migliore in assoluto”.
Ugualmente WL/WH è un disco rivoluzionario, che combina il post-soul all’hard rock in modo mirabile, riprendendo in parte alcuni suoni dal (inarrivabile e inarrivato) capolavoro con Nico, avvicinandosi già però a quello che Reed farà vedere poi in Transformer e Berlin, inutile dirlo, ugualmente capolavori.
Anthony Davis è “The Gift”, un dono rarissimo e parzialmente sprecato, che non per questo però non riesce a stupire per la sua grandiosità, perché per essere i migliori non serve necessariamente essere perfetti.
Andrew Bogut – Goblin – Tyler, The Creator
Lo so, state facendo una faccia strana mentre leggete questo paragone.
È la prova che il paragone funziona.
“I’m a fucking walking paradox, no, I’m not” utilizzare il primo verso della canzone più riconoscibile dell’album come introduzione è un espediente forse un po’ banale, ma in questo caso è talmente calzante che non potevo non farlo. Resistete ancora per qualche riga (giuro, questo pamphlet sta finendo, manca pochissimo) e provo a spiegarvi perché.
Al contrario della mano destra di questo articolo, organizzata, precisa e ordinata, io non ho un’ottima memoria.
Se Leo probabilmente può rispondervi con l’esatta partita dell’esatta stagione di una giocata che avete in mente (togliete il probabilmente se parlate di LeBron), io faccio fatica a ricordarmi anche i risultati della notte prima.
Per questo motivo, nella preparazione di questo articolo, mi sono ritrovato spesso sulla pagina di Wikipedia in cui sono elencate le prime scelte assolute dei draft NBA e, ogni volta che incontravo il nome di Andrew Bogut, prima assoluta nel 2005, rimanevo stranito.
Parliamoci chiaro, il centro australiano è quanto di più lontano ci possa essere da quello che si cerca in una prima scelta assoluta al draft (non voglio nemmeno tirare fuori da queste parentesi il fatto che fosse lo stesso draft di CP3): certamente un talento difensivo sottovalutato, comprensibile hype per uno sviluppo offensivo mai concretizzato, ma comunque strano.
Siamo abituati a pensare alle prime scelte assolute come “Star or Bust”, campioni o bidoni, e qui abbiamo un giocatore che, partendo da quella prima scelta assoluta, ha incarnato per anni il concetto perfettamente al centro dei due estremi: il giocatore utile, che ti fa vincere un titolo ma non finisce sulle riviste e nei poster celebrativi. Non credo ci siano altre prime scelte assolute in cui ciò si sia verificato così chiaramente. Anche perché pochi altri giocatori NBA hanno avuto un taglio di capelli brutto come il suo, rendendolo effettivamente inaccettabile su qualunque magazine.
Allo stesso modo, Goblin è un album strano, lavoro di un rapper strano alla testa di un collettivo strano che per tre anni aveva rilasciato mixtape strani.
È scomodo da mettere in un’etichetta, è scomodo da ascoltare: lunghissimo, inizia con Goblin, un dialogo di 6 minuti e mezzo tra Tyler e il suo ipotetico psicoterapeuta Dr. TC, accompagnato da un sottofondo da film horror. In molti pezzi è difficile individuare un ritornello, ammesso che ci sia. Leggerlo mette a disagio, con quei testi disinteressati verso qualsiasi cosa che non sia violenta e grottesca e che grondano dettagli da serial killer, versi misogini e omofobi… Un’esperienza abbastanza tetra.
Come per Bogut, diventa ancora più strano se comparato a ciò che poi è effettivamente diventato Tyler, The Creator come artista e come figura pubblica. A un occhio, e orecchio, disattento risulta difficile pensare che l’autore di Goblin sia lo stesso di Flowerboy, di Igor, la stessa persona che oggi sta ridefinendo il concetto di mascolinità nel rap game e nella cultura popolare.
Attenzione. Strano non significa scarso. Le qualità di Bogut appaiono evidenti a chiunque guardi una sua partita: la difesa, le capacità da passatore, l’intelligenza in ogni decisione. In quella famigerata trade del 2012, i Warriors non mandarono via Monta Ellis solo per liberare il talento degli Splash Brothers, Curry in particolare, ma anche per ricevere quello che diventerà il pilastro difensivo della futura dinastia Warriors, tanto con le sue qualità in campo quanto con il ruolo da mentore per Draymond Green.
Goblin è invece, molto semplicemente, un ottimo album. Potete ascoltarlo senza sapere che il rapper diventerà l’artista nominato a svariati Grammy, che allargherà i confini del concetto di hip hop negli anni a venire fino a sviluppare un suono che esula da quella stessa etichetta di genere. È un album che va ascoltato e vissuto, ti ci devi immergere. È un album con dentro Yonkers e She.
LeBron James – A Love Supreme – John Coltrane
Eccoci quindi giunti al bonus di cui avevamo parlato, il quale non può che riferirsi a un giocatore che è molto difficile, oserei dire impossibile, racchiudere in un solo album musicale, per quanto grande sia. Forse, anzi sicuramente, noi non ci siamo riusciti, ma ove il nostro intelletto ha stentato è arrivato il leggendario Scoop Jackson, che in questo articolo su SLAM illustra in modo estremamente affascinante il paragone fra i due geni dei rispettivi ambiti.
Proprio questo articolo, chiaramente (e che falliti saremmo altrimenti) non pubblicato sulla testata dalla quale prendiamo il nome, è stato infatti la primigenia fonte di ispirazione di questa rubrica e di questo pezzo, non a caso abbiamo deciso di tenerlo per ultimo, come ulteriore omaggio a ciò che ci ha dato – inconsapevolmente – il la in questa iniziativa.
Oltre ad essere davvero trascinante e a travalicare i comuni confini del giornalismo sportivo, Scoop Jackson ha il pregio di cercare di portare un po’ oltre la scrittura sul mondo cestistico, non confinandola nei suoi contorni abituali, un po’ quello che vorremmo – in questa rubrica – arrogantemente fare noi.
His greatness has become the definition of what a love for the game should look like. 👑
— SLAM (@SLAMonline) January 30, 2019
LeBron James covers SLAM 220: https://t.co/ZivCCjlrUS pic.twitter.com/uf07D2Shgt
Bene, siamo arrivati alla fine di questo articolo.
Come avrete capito, ci siamo rubati questo spazio da True Shooting perché, fondamentalmente, vogliamo parlare in maniera troppo approfondita di cose relativamente interessanti.
Se non siete fan degli articoli lunghi… credo di dovervi deludere già adesso, dubito troverete qualcosa di corto sotto queste insegne (se pensate che questo sia prolisso, non volete incontrare le videochiamate e le chat che hanno portato fino a qui).
Se invece avete apprezzato il pezzo, credo di parlare a nome di entrambi se dico che è qualcosa che ci rende particolarmente felici. TGT nasce senza un target in mente. Onestamente il pubblico potrebbe essere letteralmente io, Leonardo e i nostri ego, per cui l’idea che qualcuno all’infuori di questo quartetto abbia letto questo pezzo decisamente troppo lungo e che gli sia addirittura piaciuto beh, è tanta roba.













































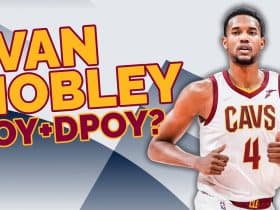



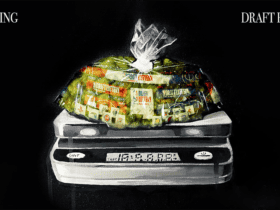








Lascia un Commento
Mostra i commenti